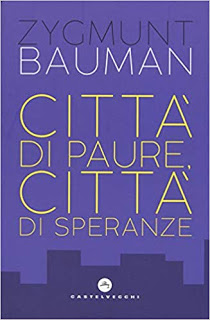Dal blog https://tempofertile.blogspot.com
Zygmun Bauman scrive questo libro del 2003, ben prima dell’accelerazione della trasformazione in corso indotta dall’improvviso palesarsi dei limiti del modello dell’accumulazione flessibile, quando la fragilità di una finanza posta al suo centro e dedita a impacchettare e distribuire natura, lavoro morto (passato, presente e soprattutto futuro), e soggettività rese subalterne via contratto, si è mostrata in piena evidenza[1]. In esso vede il processo, allora al suo esordio, della trasformazione urbana accelerante per effetto di questa attitudine ad impacchettare e distribuire[2]come l’insieme di “cambiamenti ed arroccamenti” in una sorta di rivoluzione permanente.La vecchia composizione della “modernità solida”[3] (p.19) perde strada in favore di una ricerca, ancora in abbozzo, di quella che chiama una composizione per la “modernità liquida”[4] (p.24), descritta secondo la vecchia lettura di Manuel Castells e la sua sincronia tra ‘potere dei flussi e flussi di potere’. Leggendo nel 1989 la ‘città dell’informazione’, per il sociologo che ha abbandonato in quegli anni la prospettiva marxista “i flussi di potere generano il potere dei flussi, la cui realtà materiale si impone come fenomeno naturale che non può essere controllato o previsto”. In seguito a questo esercizio di pensiero totalitario che non prevede alternative, per Castells deriva semplicemente che mentre “la gente vive nei luoghi, il potere governa attraverso i flussi” (cit., p.24). Più chiaramente, il potere (della finanza e dei network ad essa collegati e/o colonizzati), dice Bauman, “governa perchéfluisce, perché è in grado di fluire, di scorrere via. La superiorità del potere [del capitale finanziario], il suo dominio, consiste, ai giorni nostri, nella capacità di disimpegnarsi, capacità che manca in modo evidente alle persone definite territorialmente, le cui vite sono circoscritte dai luoghi”.

La forza di questo potere dei flussi, nel pieno della fase della trasformazione via finanza della capacità del territorio di fornire rendita, ha quindi una fonte molto semplice: la capacità di disimpegnarsi. E, viceversa, la mancanza di chi è sottomesso, subalterno, al capitale mobile è semplicemente il suo rovescio: essere fermo, locale, circoscritto.
Si determina insomma attraverso questa via, una divaricazione crescente tra “strati superiori”, mobili, e “strati inferiori”, fermi (p.27).
Avviene in parte una reazione: i subalterni, legati al luogo, tendono a concentrarsi sulle questioni locali e talvolta, grazie a questa fissazione i luoghi tendono a trasformarsi in città ribelli. La città diventa così un campo di battaglia, che si manifesta spesso semplicemente attraverso il rifiuto di lasciar atterrare “i flussi”. Opporsi ad una grande opera, ad un progetto urbano imponente e del quale non si riesce a trovare il senso e la scala, ad un’infrastruttura la cui ragione appartiene interamente alla logica sovralocale.
Per Bauman la città della “modernità liquida” è quindi, semplicemente, il luogo o il campo di battaglia nel quale flussi e locale si incontrano e più spesso si scontrano. Nel quale questi generano una nuova interdipendenza[5].La questione, per Bauman, diventa quella di non rispondere attraverso dettagliate e burocratiche pianificazioni (la strada dell’urbanistica novecentesca), ma lavorando a mettere insieme sicurezza e libertà.
Riprendendo la caratterizzazione della città capitalista, ovvero moderna, come luogo della convivenza tra estranei, anzi, come fabbrica di estranei, Bauman nelle conclusioni individua quindi un campo di tensione tra l’attrazione e l’avversione verso la mescolanza, senza la quale la città come la capiamo neppure esisterebbe più e quindi una tensione tra le recinzioni, le separazioni, cui l’istinto delle classi privilegiate e mobili porta e l’apertura intrinseca alla città come dispositivo della messa in contatto tra estranei (p.42).
Ma i problemi che affliggono la città post-fordista non possono essere risolti operando solo sulla sua struttura fisica, come dice Bauman “non esistono soluzioni locali a problemi generati globalmente”, l’insicurezza e la paura derivano dalla fluidità del mercato del lavoro, dalla fragilità ed incertezza che ne deriva, dalla labilità delle stesse relazioni umane, sempre provvisorie quando tutto è colonizzato dalla logica della “accumulazione flessibile”. Allora “la riforma delle condizioni esistenziali viene prima di quella della città e ne condiziona il successo. Senza una riforma di questo tipo, i tentativi, confinati nell’ambito della città, di sconfiggere e disinnescare le pressioni legate al terrore della mescolanza sono destinati a rimanere palliativi, solo placebo, il più delle volte” (p.54).
La conclusione di Bauman è disperata, manca tutto per immaginare una soluzione, perché “finora non siamo neppure vicini alla concezione, e ancora meno all’impiego, di mezzi di controllo democratico della scala e della potenza delle forze da controllare”. Ciò che bisognerebbe fare è, infatti, di “ricondurre sotto il nostro controllo le tendenze della globalizzazione al momento pericolosamente sfrenate”.
Era il 2003, cinque anni dopo cadrà il mondo della finanziarizzazione sulle nostre teste. Altri dieci anni dopo e sarà ancora lì, sulla nostra testa, rabberciato e perfettamente funzionante solo per sempre meno. I detriti continueranno ad accumularsi in quelle discariche delle ansie e delle apprensioni create dall’incertezza esistenziale che si diffonde sempre più.
Dopo il 2016, dopo tredici anni, cominciamo però a vedere che la giara è colma, e che comincia ad essere inquadrato il cuore del problema che Bauman individua, ma che non crede possa essere affrontato: la globalizzazione.
[1] – Ovviamente mi riferisco alla crisi del 2007-8, che è connessa in modo sia superficiale sia profondo alla macchina territoriale produttiva di capitale.[2] – Nel settore edilizio questa attitudine generale della finanza di incapsulare i flussi derivanti dalle rendite in una gabbia di contratti rivolti a renderli liquidi, certi ed esigibili, prende un notevole sviluppo di scala a partire da quando la stagnazione dei redditi si è resa manifesta. In particolare dopo la crisi del 2001 i consumi non riuscivano a ripartire e la disoccupazione ad essere riassorbita, inoltre le imprese industriali, a fronte della fase di implementazione delle nuove tecnologie informatiche e di espansione del “capitalismo digitale”, non usavano le risorse messe a disposizione dalla FED per assumere o fare investimenti (tra l’altro era appena finito male un ciclo di investimenti entusiasta e non c’era un’altra tecnologia di rottura immediatamente disponibile). Ma il bisogno degli USA di aiutare i ceti impoveriti era acuto. Bush senior perse le elezioni contro Clinton per aver dato la sensazione che non percepiva il problema di milioni di americani il cui reddito precipitava e che avevano perso (o temevano di perdere) il posto di lavoro.
Clinton non voleva fare la stessa fine e trovò un modo. In attesa di poter affrontare i nodi strutturali (come ricorda spesso Stiglitz, che era il suo consigliere economico, sviluppò una politica a largo raggio in favore dell’istruzione e della estensione delle reti di protezione, in parte fallita), l’Amministrazione promosse un’espansione del credito in favore dei ceti più deboli. L’occasione e lo strumento erano le agenzie pubbliche Freddy Mac e Fannie Mae che furono dunque incaricate di estendere la loro politica di sostegno ai mutui (che andava avanti dagli anni trenta) verso i ceti più deboli. Per farlo cominciarono a cartolarizzare i titoli di debito (una tecnica antica) in modo più aggressivo. Bush junior potenziò oltre ogni limite tale politica, cercando di far avere “una casa a tutti”. La soluzione di minore resistenza a disposizione. Le agenzie passarono da erogare 87 Mld di mutui nel ’97 ai 400 Mld di dieci anni dopo. Il sistema finanziario americano fece allora da tramite tra i risparmiatori tedeschi e giapponesi (ma anche cinesi e indonesiani) e i mutuatari “subprime” americani. Si è attivato un sistema globale nel quale alcuni paesi con consumi interni deboli e grandi esportatori (dunque con grandi riserve) hanno venduto a credito le loro merci ai consumatori americani (che in alcuni anni sono arrivati ad assorbire il 70% del risparmio mondiale), tramite il mercato immobiliare.
Naturalmente il settore pubblico ha iniziato (e, ad esempio, Stiglitz nel 2009 in Bancarotta, nega che sia stato così decisivo), ma il settore privato si è con entusiasmo unito alla festa.
Qui si manifesta la diversità di obiettivi tra democrazia e capitalismo: il denaro facile erogato dalla FED ed utilizzato dalle agenzie pubbliche, viene a contatto con le ragioni del profitto di un settore finanziario sofisticato, competitivo ed amorale e quindi le buone intenzioni si trasformarono in un disastro. Si generarono un compatto insieme di conseguenze non volute. Ad esempio, le agenzie non avevano la struttura per erogare direttamente i mutui nella quantità che la politica voleva, quindi li comprarono da altri e li rifinanziarono. Ma, abituate dagli anni trenta ad un’erogazione di primo livello, non avevano neppure la capacità di valutare questo diverso mercato. E fecero poche domande. Questo fece degradare progressivamente la qualità del credito. Come capita sempre, il prezzo si pagò quando i prezzi cessarono di salire e cominciarono a scendere.
Durante questa espansione sono stati costruiti strumenti di gestione del rischio sempre più sofisticati che, in realtà, servivano ad occultare i rischi e non farli vedere. La ragione è semplice: se non si vede il rischio che è remunerato dallo strumento (esempio da un contratto assicurativo) sembra che il manager che lo ha generato abbia avuto una prestazione sopra la media (una prestazione “alfa”, nel gergo della finanza) e quindi meriti i dovuti premi. È partita quindi una corsa a fare “leva” sempre più elevata di cui nessuno si preoccupava. Ad esempio durante il boom immobiliare i prestiti ai ceti più poveri (i cosiddetti mutui sub-prime) sono cresciuti molto più di quelli normali, ma il 60% dei titoli garantiti da attività patrimoniali era classificato con la tripla A che normalmente viene attribuita solo all’1% dei titoli. Il meccanismo era quello delle tranche per cui, in sostanza, un titolo AAA poteva diventare insolvente solo se quasi tutti fossero diventati insolventi. Questo è importante perché genera il cosiddetto “rischio di coda” (tail risks), quella classe di rischi che si posizionano all’estremità di una distribuzione di probabilità. Sono molto improbabili. Su questa base AIG impegnò capacità di assicurazione molto superiori alla sua capacità di restituzione e non si controassicurò abbastanza. Considerava l’evento di una generale crisi di solvibilità in tutti gli Stato Uniti (unita ad un calo dei valori immobiliare significativo e generale) troppo improbabile.
Perché? In fondo tutti sanno che il mercato immobiliare è soggetto ad oscillazioni e che ogni una decina di anni si presenta una crisi. La spiegazione è che i manager erano alla ricerca spasmodica, come i loro azionisti, di una performance “alfa” (cioè superiore alla media dei rendimenti di settore) perché questa, opportunamente pubblicizzata avrebbe portato altri capitali, altri dividendi e alti bonus. Il modo più facile è assumersi un rischio di coda senza dirlo (altrimenti si vedrebbe che la remunerazione straordinaria è a fronte di un rischio alto e non sarebbe tecnicamente superiore alla media di settore). In sostanza le organizzazioni “rischiano la pelle per qualche soldo” (e lo fanno rischiare a noi).
A questo punto bisognerebbe chiedersi perché nessuno li ha fermati in tempo. Bisogna indagare sul comportamento degli uffici di gestione del rischio (piccoli, sottopagati e rapidamente puniti quando alzavano la voce), dei CEO (anziani, poco informati e sicuramente più interessati ad emergere nel loro mondo ipercompetitivo che non ad avere basse performance. Fa eccezione Jamie Dimon di JP Morgan), gli azionisti (interessati solo a breve termine). In sostanza, alla fine, questo comportamento era il più logico data la promessa della FED di arrivare a salvare il mercato se si fosse incartato. In sostanza il gioco era “testa vinco io, croce perde la FED”. A questo punto per i CEO (salvo che per Fuld di Lehman Brothers) era logico ballare fino a che andava la musica, al momento di fermarla sarebbe arrivata la cavalleria. Tutti i profitti sarebbero rimasti a casa e le perdite assunte dal Governo. La stessa logica informava gli azionisti.
Insomma, i salvataggi fanno molto male prima di essere effettuati. Sono una sorta di profezia che si autoavvera. Inoltre una eventualità che riduce anche il premio di essere stati saggi. Infatti un comportamento più prudente, con più riserve e capitale liquido, ha il vantaggio di potere comprare assett sottovalutati quando gli altri vanno in difficoltà, ma se il Governo ne sostiene il valore con fondi pubblici (programma TARP), allora Dimon, ad esempio, che si è ritirato un attimo prima ha sbagliato tutto. Non ha ballato prima e non ha festeggiato dopo. [3] – Il termine, proprio di Bauman, si riferisce alla città industriale fino alla versione fordista (dal XIX al terzo quarto del XX secolo) ed alla contrapposizione capitale/lavoro che la contraddistingue. O, per come la descrive, tra la politica e l’economia. Il Welfare State è il punto di arrivo di questa lotta, necessario perché sia il capitale, e la logica economica, sia il lavoro, e la logica politica, erano radicati nei medesimi territori, fissi, privi di capacità di movimento.[4] – Viceversa, dall’ultimo quarto del XX secolo una delle due parti in lotta si è liberata, la globalizzazione dell’economia da divaricato i termini, e, come sottolinea Castells, per reazione quelli che non potevano essere mobili si sono rinchiusi nella difesa del proprio. Come scrive in “Il potere delle identità” al venire meno di quelli che chiama “movimenti propositivi (il movimento operaio e i partiti politici)” le fonti di resistenza alla logica unilaterale del capitalismo, ma anche allo statalismo (ovvero alla riduzione burocratica) non è rimasta scelta che reagire in base ad un “principio più immediato di auto-riconoscimento e organizzazione autonoma: il localismo”. Affiora un paradosso che vede una politica sempre più rivolta al locale mentre il mondo si struttura secondo processi sempre più globali. In definitiva “vie era una produzione di senso e di identità: il mio quartiere, la mia comunità, la mia città, la mia scuola, il mio albero, il mio fiume, la mia spiaggia, la mia chiesa, la mia pace, il mio ambiente. Ma si tratta pur sempre di un’identità difensiva, di un’identità asserragliata nella trincea di ciò che è familiare contro l’imprevedibilità dell’ignoto e di ciò che non può essere controllato” (p.67). In questi termini le identità che emergono dalla volontà di controllo degli spazi ‘propri’ conducono ad una sorta di “individualismo collettivo” (Castells, p.68).[5] – È del tutto ovvio, infatti, che lo spazio dei flussi necessità dell’altro (del luogo), e viceversa. Banalmente, se non ci sono valori locali da “impacchettare” non ci può essere distribuzione attraverso la rete della alta finanza, cfr. p.33.