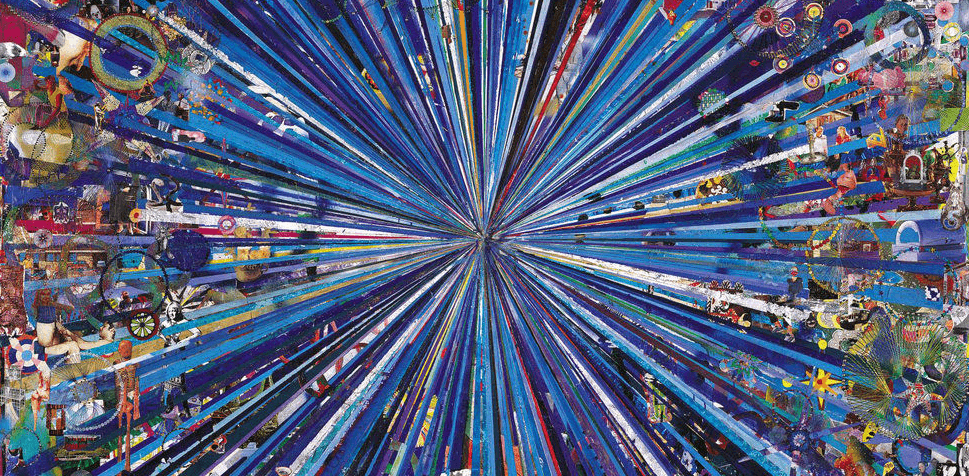Dal blog https://www.lafionda.org/
2 Ago , 2025|Antonio Semproni
In città le zone preferite per la sosta si trovano ai margini o lungo il perimetro di uno spazio (Jan Gehl, Vita in città. Spazio urbano e relazioni sociali, Maggioli, 1991, pag. 161): la posizione periferica “permette di dominare meglio un’area, dal confine verso l’interno”. “Con le spalle protette, gli altri possono avanzare solo frontalmente”: le zone marginali offrono dunque il vantaggio di potersi riparare dal traffico di stimoli che permea il campo visivo o, quantomeno, di poterlo mitigare, facendo sì che gli elementi emergano progressivamente, modulandosi a seconda della posizione che si trovano man mano a occupare e dunque della distanza dal nostro sguardo.
Nello spazio digitale non disponiamo di un cantuccio dal quale assistere a ciò che ci circonda senza che esso si imponga di soprassalto: gli elementi, i contenuti sui quali si concentra la nostra attenzione emergono uno alla volta e tutti d’un pezzo. Non abbiamo alcun potere di negoziare l’attenzione che ci richiedono: o la accordiamo o la revochiamo (scrollando). Inoltre, ciascun elemento o contenuto si pone alla medesima distanza da noi: questo posizionamento produce un’impressione di indifferenziazione, che ci agevola nel passare senza turbamento attraverso i contenuti più disparati. La finestra sullo spazio digitale – rappresentata concretamente dallo schermo del nostro smartphone – è una zona nella quale coltivare indifferenza e distrazione: quest’ultima è da intendersi nel senso che ogni elemento ci distoglie dal precedente e a sua volta è destinato a scomparire dal nostro fascio di attenzione al sopraggiungere di un ulteriore elemento. L’equivalenza di un contenuto all’altro sotto il profilo del suo posizionamento nello spazio digitale sancisce l’equivalenza di un contenuto all’altro per quanto riguarda il suo significato di merce.
Sostare allo scopo di visualizzare l’ambiente circostante è un’esigenza connaturata all’essere umano. Gli studi sugli spazi urbani dimostrano che le zone di sosta e i punti di seduta “che offrono una buona visuale sulle attività circostanti risultano più usate di quelle con poca o nessuna vista sugli altri” (Jan Gehl, op. cit., pag. 31). “Quando qualcuno decide di sedersi in un ambiente pubblico, quasi sempre è per godere dei benefici del luogo: (…) la vista di quanto succede intorno e, possibilmente, tutto l’insieme (…) posti a sedere ben protetti, anche dagli agenti atmosferici, con una buona visuale diretta sulle attività circostanti, saranno preferiti di gran lunga agli altri”: così spiega l’architetto danese Jan Gehl (op. cit., pag. 171).
I dispositivi digitali, con il loro schermo liscio e obbediente alle sollecitazioni dei nostri polpastrelli, promettono di costituire un punto di sosta e osservazione estremamente confortevole, tanto che possiamo portarceli appresso con estrema facilità, quasi noncuranza, e servircene quando vogliamo. Promettono, perdipiù, di far coincidere l’insieme passibile di osservazione con il mondo, anzi l’oggetto-mondo.
La questione dell’affaccio allo spazio urbano e allo spazio digitale è strettamente legata a quella del flusso di stimoli al quale siamo soggetti quando accediamo all’uno o altro di questi spazi. Quali forme e caratteristiche assume rispettivamente simile flusso in ciascuno di questi spazi?
Prima della rivoluzione industriale le dimensioni delle città erano contenute: vi era la necessità di circondarle di fortificazioni che le proteggessero ed era opportuno che la distanza da percorrere tra le abitazioni e i luoghi di lavoro fosse di poco conto, considerato che solo una minoranza di privilegiati potevano permettersi di possedere o noleggiare una carrozza con cavalli. La distanza percorribile aumentò in seguito alla rivoluzione nei mezzi di trasporto (con l’invenzione di veicoli – prima a vapore e poi a trazione elettrica – che si muovono su binari), la quale fece sì che la città si articolasse in zone separate: commerciale, industriale, residenziale, il centro storico, i sobborghi, il ghetto ecc.; mentre la rivoluzione nei mezzi di produzione diede impulso all’industria, così che la città incrementò la propria popolazione e di conseguenza ampliò la propria area (Arnold Toynbee, La città aggressiva, Laterza, Bari, 1972, pagg. 211-213).
La separazione della città in quartieri corrisponde alla divisione della società in classi, sancisce anzi architettonicamente – edunque dietro progetto e per opera dell’essere umano – questa divisione. Chi si sposta da un quartiere all’altro della città avverte la separazione in classi. Chi si inoltra nello spazio digitale avvista riuniti entro una sola infrastruttura gli esponenti di tutte le classi. Lo spazio digitale riunisce ciò che è diviso mantenendolo tale, perciò è più subdolo (e più efficiente sotto il profilo del contenimento del conflitto sociale) di qualunque pianificazione urbanistica.
La città chiusa, convergente su un unico punto centrale, è stata rimpiazzata nel corso della rivoluzione industriale da una città sottoposta e aperta a ogni tipo di fluttuazione. Il traffico è diretto in tutti i sensi e non può addensarsi soltanto attorno alla piazza del mercato e a quegli altri luoghi d’incontro tradizionalmente deputati all’assolvimento delle funzioni sociali fondamentali, quali lo svolgimento di assemblee politiche, la soluzione di questioni giudiziarie e la celebrazione di cerimonie religiose (Arnold Toynbee, op. cit., pagg. 284-289). A Tokyo – come racconta Roland Barthes ne L’impero dei segni (Einaudi, 1984, pagg. 39-42) – si verifica un fenomeno inconsueto: il visitatore gira attorno a un centro che è vuoto, “interdetto e indifferente, dimora mascherata dalla vegetazione, difesa da fossati d’acqua, abitata da un imperatore che non si vede mai” (vi ha sede il Palazzo Imperiale, inaccessibile, circondato da canali e giardini l’accesso ai quali è regolamentato più o meno strettamente): il centro è emblematico della sospensione del flusso comunicativo, del silenzio che interdice i traffici e costringe “la circolazione [della comunicazione] a una deviazione perpetua”.
Il centro di Tokyo rappresenta un’oasi di salvezza nella misura in cui lo spazio urbano, al pari di quello digitale, è sovraffollato. Il primo è costipato dal traffico di valori d’uso (merci e lavoro) e di scambio (denaro), il secondo dal traffico di dati e immagini in cui è smaterializzata la realtà, di quelle che Byung-Chul Han chiama “non cose” (cioè informazioni cui accedere piuttosto che oggetti da possedere: v. Le non cose, Einaudi, 2023, pag. 18), cui possono corrispondere non solo valori d’uso e di scambio, ma anche valori-segno (che cioè collocano il loro possessore in una determinata posizione sociale).
L’ambiente semiotico urbano è dominato dalle insegne di banche, negozi, locali di ristorazione e grandi magazzini, dunque da segni che offrono beni e servizi da acquistare, in pratica merci. Questi segni vorrebbero solleticare i nostri desideri con la più palese ingenuità e sfacciataggine: essi non dimostrano alcuna astuzia, rivelando a colpo d’occhio la loro ragione commerciale (ed effettivamente le insegne spesso riportano per intero la ragione sociale dell’azienda): ce li lasciamo tranquillamente alle spalle mentre passeggiamo. In Taxi Driver Robert De Niro scivola a bordo del proprio taxi oltre le insegne luminose dei negozi e dei caffè; il suo personaggio (Travis Bickle) è mosso dal proposito di ripulire “le strade dall’immondizia”, cioè dai paria e dagli outsider di New York. Accecato a tal punto dalla sua missione, nemmeno si impegna a decifrare la rispettiva posizione occupata nella piramide sociale dalle persone contro cui si scaglia di volta in volta: per lui “non fa differenza” che si tratti di un magnaccia, di un rapinatore disperato o del candidato alla carica di sindaco. Non arriva nemmeno a intuire la relazione tra il tipo di sviluppo che le scintillanti insegne notturne denotano (cioè lo sviluppo urbano trainato dal capitale) e l’emarginazione sociale che a esso si riconnette. Per questo finirà per essere ben accetto da quella classe media (impersonata da Cybill Shepherd nei panni di Betsy) che crede ciecamente in questo tipo di sviluppo e che in un primo tempo aveva allontanato Travis ritenendolo un soggetto deviante.
In definitiva, le insegne della città traspongono il capitale in termini architettonici, ma non sono idonee a garantire l’assorbimento della sua sovrapproduzione, cioè a integrarci, quali consumatori, nel ciclo di produzione e consumo e, dunque, nella mega-macchina di accumulazione.
L’ambiente digitale è invece congeniale al realizzarsi di questa integrazione. Il discorso del capitale, lungi dall’esaurirsi nelle inserzioni pubblicitarie, è sussunto dagli influencer, dalle figure pubbliche (le c.d. spunte blu dei social) e, più in generale, da tutti coloro i quali, scientemente o meno, espongano i propri stili di vita mercificati (tra i quali rientrano senz’altro, a titolo di esempio, i piatti di pasta preparati in casa e la lista dei loro ingredienti presi al supermercato, i concerti a cui si è assistito nel corso dell’anno, i festeggiamenti per il conseguimento di un titolo di studio presso un prestigioso istituto privato ecc.), cioè fondati sull’acquisto di merci. Quel che non è mercificato (ben poco) è comunque potenzialmente mercificabile: nello spazio digitale quanto in apparenza si colloca al di là della logica del capitale (il frutto di una creazione intellettuale, la testimonianza di un fatto della vita privata ecc.) o diventa merce (suscita le interazioni degli utenti, che gli conferiscono capitale simbolico, cioè la capacità di attrarre attenzione, molto appetita sul mercato) o suscita l’indifferenza, la quale costituisce la sanzione per ciò che non è abbastanza performante da arricchire l’immaginario collettivo, da stimolare gli altrui desideri (e dunque i consumi).
Nello spazio digitale riusciamo a trasportarci senza fatica né impegno, in altre parole senza gli ostacoli tipici del traffico stradale urbano. Il traffico che caratterizza lo spazio digitale coincide con il flusso ininterrotto di dati semantici, accelerato rispetto ai flussi comunicativi che hanno ordinariamente luogo nel mondo reale. Anche quando crediamo di muoverci entro questo spazio, per il fatto di cambiare pagina web, social media o app oppure ricaricare il feed della home, in realtà non ci siamo mossi di una virgola. Rimaniamo in ogni caso al centro, nel senso che siamo l’oggetto sul quale converge il flusso innumerevole di dati, e continuiamo a essere questo oggetto indipendentemente dalla quantità di contenuti che scorriamo. In senso idealistico, trovarci al centro ci dà la sensazione che il mondo sia un oggetto sottomesso alla nostra coscienza, un qualcosa che esiste per noi anziché di per sé; nella prospettiva materialistica, invece, noi non siamo altro che incorporati alla struttura economica capitalista, smaterializzata nello spazio digitale, e vi siamo incorporati a tal punto che ci troviamo sempre e comunque al suo centro. È impossibile defilarsi e così arrivare al vuoto, al negativo, al non-essere, perché il ciclo dell’economia capitalista conosce al limite la crisi, ma non la soluzione di continuità.
Nelle cittadine italiane di fondazione medievale la piazza principale, oltre a ospitare gli edifici sede dei governi comunali (di allora e spesso, a seguito di riconversione, anche di oggi), presenta un lato scoperto che affaccia sul paesaggio e dunque sulla natura, su ciò che si oppone radicalmente alla civiltà (Luca Molinari, La meraviglia è di tutti, Einaudi, 2023, pagg. 11-15).
Lo spazio digitale, al pari di molti spazi urbani contemporanei, ha sottratto all’uomo lo sguardo sul paesaggio, sull’infinito dato dalla natura e sul suo mistero. In esso ci immergiamo in un ambiente chiuso dove i contenuti finiti si riproducono tendenzialmente all’infinito: una metropoli alla cui base si agita un perenne cantiere e il cui scenario è costantemente soggetto a cambiamenti.
L’architettura dello spazio digitale ha plasmato il nostro immaginario e in particolare le nostre prospettive sullo spazio urbano. L’ideale oggi dominante è quello di una città muscolare e proliferante, che valorizzi tutto quanto è mercificabile (e allarghi il campo del mercificabile), secondo la logica del capitale. L’estasi dell’essere umano contemporaneo sta nel saturare la propria attenzione con le cose offerte in vendita o pronte a essere colonizzate (lo spazio aereo invaso dai grattacieli), anziché nella contemplazione della natura, del vuoto, di ciò con cui non può avere luogo alcuno scambio di valori per il fatto che si sottrae (per ora!) alle pretese del capitale. La lotta avverso l’ambiente digitale e quegli inferni urbani la cui architettura si va sempre più conformando a questo ambiente passa attraverso il recupero di una simile contemplazione, la cui pratica può riconfigurare la nostra sensibilità verso i confini di quanto è mercificabile. Uscire dallo spazio digitale e dalle grandi metropoli, nelle architetture dei quali si riflette la ragione del capitale, è necessario per educare in tal senso la nostra sensibilità – intesa come intelligenza percettiva, cioè comprensione del mondo e delle cose attraverso i sensi – e, di conseguenza, la nostra coscienza politica.
Di: Antonio Semproni