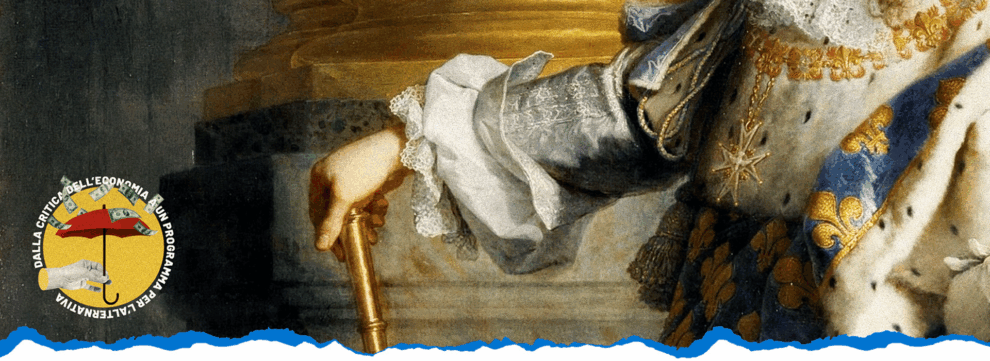Marco Bertorello Emanuele Felice 31 Ottobre 2025
Di fronte al fallimento neoliberale e in mancanza di alternative, dice Emanuele Felice, rischia di affermarsi una visione della disuguaglianza come ordine naturale delle cose che conduce alla guerra mondiale
Abbiamo lanciato un appello «a chi si occupa di economia» per ragionare e confrontarsi collettivamente sulle pagine di Jacobin Italia con l‘obiettivo di andare oltre la critica nella sfera economica e avanzare proposte concrete per un programma alternativo. Il primo con cui dialoghiamo è Emanuele Felice, docente di storia economica all’Università Iulm di Milano e curatore del Festival dell’economia critica della Fondazione Feltrinelli.
Ritieni siano maturi i tempi per un contributo fattivo a partire dalla critica del regime economico esistente? Un contributo che abbia uno sbocco politico, nel senso più pregnante e alto del termine? Mi pare che già il titolo del tuo ultimo libro (Manifesto per un’altra economia e un’altra politica, Feltrinelli, 2025) vada in questa direzione.
Io credo di sì. I tempi sono maturi sia negli Stati uniti, e non da oggi, dove il fallimento del modello neoliberale è drammatico e plateale, sia nell’Unione europea. Qui dobbiamo fare i conti con maggiori difficoltà, oggettive, per le modalità di funzionamento delle istituzioni comuni (che ostacolano politiche di cambiamento sia a livello nazionale che confederale). Nondimeno è opinione diffusa, nella società, che l’attuale modello economico produca disuguaglianze, distrugga l’ambiente, metta in crisi la democrazia. Aggiungo io (questo forse è meno chiaro nell’opinione pubblica), che rallenta anche la produzione e diffusione dell’innovazione. Se non cambiamo, adesso, il nostro modello di sviluppo, andremo incontro al tecno-fascismo, alla catastrofe ambientale e probabilmente anche alla terza guerra mondiale.
Spetta alla politica, democratica e progressista, organizzarsi per realizzare il cambiamento. Ma è qui il deficit principale di consapevolezza e di iniziativa. Dal mondo delle idee, dagli intellettuali, può venire però un contributo importante affinché questa «coscienza sociale del cambiamento», chiamiamola così, acquisti forza, organicità e si trasformi in un’azione politica incisiva. In fondo è per questo che ho scritto il Manifesto.
Più in generale ritengo che i processi storici, e anche le svolte epocali, si determinino non solo in base alle condizioni economiche e sociali, che pure sono fondamentali, ma anche in virtù di un’acquisizione di coscienza da parte dei soggetti del cambiamento, sul terreno della cultura in senso lato. È una posizione simile alla nota tesi gramsciana, ma per certi versi anche Marx aveva questa visione, al di là della caricatura che alcuni fanno del suo pensiero. Negli ultimi decenni abbiamo avuto diverse conferme dell’importanza dell’«egemonia culturale» nella battaglia politica. Per esempio, è proprio così che i neoliberisti hanno imposto la loro egemonia: prima vincendo sul piano culturale (già negli anni Settanta, negli Stati uniti), poi su quello politico, economico e sociale.
Prendiamo di petto la questione. Il mercato è tornato a essere il centro del sistema economico. La sua pervasività è forse circoscritta unicamente dalla ragione geopolitica. Ma, come sottolinea Paul De Grauwe, nell’economia contemporanea è come se vi fosse un pendolo che oscilla tra un capitalismo fondato sull’estensione massima del mercato e uno dove la gestione pubblica torna a essere importante. Ora siamo giunti all’oscillazione massima nel lato del mercato, evidenziandone i limiti. Proverei a sottrarmi a questa legge del pendolo. Provando a immaginare una società dove il mercato rimane una sfera circoscritta nell’ambito delle attività economiche, e accompagnata da una sfera pubblica e da una gestita in maniera innovativa direttamente dai cittadini. Insomma un modello che stabilmente toglie centralità al mercato senza annullarlo, e che sperimenta formule economiche nuove, tese al perseguimento dell’uguaglianza assieme alla tutela ecologica della Terra, anche attraverso dosi di pianificazione. Mi pare che tu parli della necessità di ricomporre «il sogno dell’umanità» evitando di seguire esclusivamente la logica competitiva per fare posto a quella cooperativa.
Esatto. Il problema è duplice. Primo, il mercato ha occupato ogni sfera dell’economia, con il risultato che la logica competitiva ha schiacciato quella cooperativa e, in questo modo, è risultata mortificata anche la partecipazione (che è la vera via attraverso cui l’economia produce progresso e benessere diffuso, ed è l’obiettivo cui sia la competizione sia la cooperazione dovrebbero tendere: includere, anziché escludere). Secondo, la logica mercatista ha invaso anche le altre dimensioni delle attività umane, strabordando dall’economia: si è imposta sull’etica, ha dominato la politica, ha contaminato la linfa delle relazioni sociali e spesso finanche personali.
Da questo punto di vista, il neoliberalismo è arrivato pienamente a configurarsi come l’ideologia politica (e non certo solo come un insieme di ricette economiche) del nostro tempo. Tutto ciò ha avuto conseguenze anche sulla percezione che abbiamo dell’economia. Si è fatta strada l’idea che il capitalismo di mercato sia immodificabile e che, comunque, è meglio non intervenire; anzi, che tutto quello che dovrebbe fare la politica è cercare di assecondarlo. Correlata a questa, è andata avanti anche l’idea che la scienza economica sia una disciplina dalle regole oggettive, «dura», come la fisica o la chimica. In sostanza, si è imposta la convinzione del there is no alternative: forse la principale battaglia culturale, pre-politica, vinta dai neoliberali.
Fatta questa premessa, oggi l’idea dell’egemonia del mercato, soprattutto nella sfera economica, è fortemente messa in discussione. Da più versanti si torna a parlare di intervento pubblico. Soprattutto da parte della nuova (estrema) destra e dei regimi autoritari: protezionismo, complesso militare-industriale, controllo delle informazioni. E infatti rischiamo di finire nel tecno-fascismo. Rimane però, a livello pre-politico, e più in generale nella società, la convinzione che l’attuale modello economico sia immodificabile, che i rapporti di forza non si possano non dico rovesciare, ma nemmeno provare a cambiare.
È una situazione che ricorda per molti versi quella dell’ancien régime, precedente la Rivoluzione francese: quando si pensava che quel mondo fondato sulla disuguaglianza per legge, non solo sostanziale ma addirittura giuridica, fosse l’ordine naturale delle cose.
Ora, quando io parlo di «ricomporre il sogno dell’umanità» mi riferisco anche a questa dimensione più ampia. Dobbiamo acquisire consapevolezza che la narrazione culturale dei neoliberali è falsa e nociva (così come è falso che l’economia sia una scienza esatta) e, da qui, tornare a proporci come artefici della nostra storia. La politica democratica, vale a dire, deve tornare a guidare l’economia, e non farsene guidare: orientandola ai fini posti dall’etica progressista. Questi sono i fini della progressiva estensione dei diritti, non solo civili e politici ma anche sociali e ambientali; e dei correlati doveri, che in sostanza pongono limiti alla libertà economica (ad esempio per garantire i diritti sociali e ambientali). È a questo che deve servire l’economia: a realizzare questi obiettivi, indirizzata dalla politica democratica. L’economia è ancella dell’etica e della politica, non sua padrona. Ed è solo a partire da questa consapevolezza che possiamo ricostruire il sogno (progressista) dell’umanità.
Il terreno su cui provi a misurarti è quello del «che fare?». Da un fallimento storico del mercato deduci un ritrovato ruolo dello Stato e della società. Quale equilibrio c’è tra una rinnovata sfera pubblica e la scoperta del potenziale cooperativo della società?
Prima di tutto lo Stato deve intervenire per correggere le enormi ingiustizie create nei nostri sistemi fiscali: il fatto che i multimilionari paghino, in media, una percentuale di tasse minore della gran parte dei cittadini, perché i loro redditi derivano in gran parte dal capitale che viene tassato molto meno del lavoro. E i multimilionari vedono così crescere progressivamente la loro fetta di ricchezza sul totale (oltre alla loro ricchezza assoluta), trasmessa poi per via ereditaria, con poco o nulla interesse a investirla in attività produttive. Di nuovo, come ai tempi dell’ancien régime (mi piace insistere su questa analogia, in una rivista che si chiama Jacobin).
Dopodiché, nella sfera economica l’intervento pubblico ha, storicamente, quattro doveri che lo giustificano, a fronte dei rischi, dei costi (e delle disfunzioni) che pure può comportare. Parlo dello Stato programmatore, regolatore, investitore e innovatore. Aggiungo: corrispondono ai ruoli che esso ha già rivestito, ad esempio nell’«età dell’oro» dopo la Seconda guerra mondiale, anche con un certo successo. Nessuno di questi ruoli è stato, invece, pienamente svolto negli ultimi decenni (nemmeno quello regolatore: l’Antitrust ha avallato, ad esempio, le fusioni fra le imprese della new economy che hanno creato grandi monopoli in violazione della concorrenza, come l’acquisizione di Instagram e WhatsApp da parte di Facebook). Ma oltre a uno Stato regolatore, che sappia porre un freno ai poteri economici, noi abbiamo bisogno di uno Stato capace di programmare (oggi peraltro tutto ciò è più facile rispetto al passato, grazie all’intelligenza artificiale e ai big data, come hanno capito in Cina); e quindi di investire in alcune aree di prevalente interesse pubblico, e di promuovere l’innovazione, in modo diretto e indiretto: ad esempio nella conversione ecologica, oppure in settori strategici come i satelliti e i big data, o nella sanità e nella ricerca biomedica.
Lo Stato, poi, deve fare emergere il «potenziale cooperativo della società», come tu dici, con opportune norme. Sia norme di sistema, generali: ad esempio, nel Manifesto insisto molto su un’istruzione pubblica e di qualità, anche come base per una più ampia inclusione e partecipazione, in direzione opposta a quanto avvenuto negli ultimi decenni quando l’istruzione è stata privatizzata e, se di qualità, è tornata a essere privilegio dei più ricchi. Oppure sul finanziamento della ricerca scientifica di base, che deve essere pubblica e condivisibile, e dove al sistema dei brevetti (escludente e oggi controproducente, anche perché controllato dalle multinazionali) va sostituito quello dei premi (che invece favoriscono la massima condivisione dell’innovazione, oltre che la sua creazione). O ancora, sul ruolo del sistema creditizio, che va riformato per far sì che torni a favorire chi vuole investire in attività d’impresa, disincentivando invece la finanza speculativa. Sia poi norme specifiche: quelle che consentono la partecipazione dei lavoratori alle decisioni di impresa, che vanno incontro alle imprese eticamente responsabili (ma a condizione che lo siano davvero), oppure, per stare al tema ambientale, che promuovono le comunità energetiche per la diffusione delle energie rinnovabili.
Il «potenziale cooperativo della società» (è bella questa tua espressione!) risulta importante anche per controllare e migliorare l’intervento pubblico, aiutando a ridurre il rischio di degenerazioni, di tipo clientelare o anche illiberale, o quello della burocratizzazione. In generale si tende a pensare che l’intervento pubblico debba stare sui grandi temi, sulla dimensione macro, la partecipazione sociale invece su quella micro e sul locale. Non è sempre vero. La partecipazione sociale può coordinarsi bene con l’intervento pubblico, migliorandolo, anche a livello nazionale e internazionale: ad esempio nella conversione ecologica, promuovendo la mobilitazione sociale e culturale su grandi obiettivi condivisi che devono vedere una compartecipazione di privato, pubblico e non profit, e hanno bisogno di una piena consapevolezza culturale. Qualche esempio di queste «grandi missioni»? La pulizia degli oceani e dei mari. Oppure il graduale superamento degli allevamenti intensivi.
Le regole del gioco democratico sembrano diventate incompatibili con l’economia. Le istanze liberali vengono paradossalmente negate proprio dal campo liberista. Da qui niente concorrenza per favorire i monopoli, insofferenza per l’equilibrio dei poteri, contrazione di tutto ciò che intralcia il primato della sfera economica. Ma forse per riportare «nei suoi ragionevoli confini» l’economia c’è bisogno anche di creare nuove istituzioni di controllo e partecipazione. Nel libro, riprendi la proposta del Forum Diseguaglianze e Diversità dei «Consigli del lavoro e della cittadinanza». Come reinventarsi una democrazia radicale all’altezza della complessità dei problemi economici che stiamo vivendo?
La proposta del Forum a me sembra un buon esempio di come lo Stato possa favorire la partecipazione nell’economia: una partecipazione orientata a obiettivi sociali, ambientali e anche alla diffusione dell’innovazione (che è il vero motivo, di fondo, della crescita della produttività). Per quanto riguarda la sfera politica, occorre ridare forza ai partiti, con il finanziamento pubblico e vincolandolo a democraticità e trasparenza; bisogna prendere atto che la logica maggioritaria è fallita, rispetto al proporzionale, e che i sistemi parlamentari funzionano meglio di quelli presidenziali, nel garantire le libertà fondamentali e anche i diritti sociali.
Occorrono poi regole sull’utilizzo, condiviso e trasparente, dei social network, dell’intelligenza artificiale e dei big data nell’arena pubblica, limitando l’impatto delle fake news e cercando di evitare che alcuni abbiano posizioni dominanti a scapito di altri. Bisogna anche ridare idealità alla politica e sostenere l’azione dei partiti con fondazioni di studio: per creare una classe dirigente più competente e meglio interessata al bene pubblico. Parlo di riforme che dovrebbero essere al cuore del programma delle forze progressiste di tutti i paesi democratici e, naturalmente, dell’Italia.
Perlopiù avanzi proposte concrete, attuabili qui e ora. L’impressione è quella che abbiano una portata più sovversiva di quel che sembra. Cioè che l’attuale sistema di supercompetizione non sia mai disponibile ad accogliere correzioni di rotta. In poche parole che sia irriformabile. Accettare anche solo alcune delle proposte concrete che tu fai, dall’Agenzia mondiale per l’acqua all’armonizzazione fiscale, passando per un catasto mondiale dei patrimoni finanziari o per la costruzione in Europa di imprese pubbliche transnazionali, non rischierebbe di far implodere l’attuale sistema economico-finanziario?
Sicuramente lo cambierebbero radicalmente, orientandolo alla riduzione delle disuguaglianze, alla salvezza dell’ambiente e anche della democrazia. In passato il capitalismo è stato riformato, con successo, senza per questo venire distrutto: anzi, proprio le riforme realizzate (da sanità e istruzione pubblica, ai diritti dei lavoratori) lo hanno rafforzato, evitando che implodesse; e hanno rafforzato anche la democrazia.
Ciò detto, per il futuro, non è che la storia si debba ripetere necessariamente uguale, per cicli. La storia non ha leggi. Per questo, io non ho una risposta certa su dove ci porterà questa riforma radicale del capitalismo che vorrei fosse presa seriamente in considerazione. Perché la risposta non esiste, dipenderà dalle nostre scelte.
Più che ragionare in astratto nelle «osterie dell’avvenire» (avrebbe detto Marx), noi dobbiamo riflettere in concreto su come avviare il processo e poi seguirlo, tappa dopo tappa, mantenendo legate le ragioni della libertà con quelle dell’uguaglianza (che peraltro, secondo me, sotto certe condizioni non sono contrapposte ma si rafforzano a vicenda); ovvero l’orizzonte della progressiva estensione dei diritti, cui ancorare l’innovazione tecnologica. Detta altrimenti: noi dobbiamo porre le condizioni affinché le chances che un cambiamento auspicabile dalla maggior parte dell’umanità abbia inizio, e prenda la strada desiderata, siano le più alte possibili.
I problemi che poni hanno spesso soluzioni sul piano internazionale. Ti avanzo un dubbio: nel tuo libro proponi di tornare alla liberalizzazione del commercio internazionale per smantellare l’assetto neoprotezionista creato negli ultimi anni. Ma quest’ultimo non è forse il risultato del dispiegarsi di una libertà sfrenata del capitale degli ultimi decenni?
Lo è. E infatti io distinguo fra la liberalizzazione della finanza (dannosa per i diritti sociali e anche improduttiva, perché favorisce la rendita e distoglie risorse dall’innovazione) e quella del commercio, che invece ha contribuito a far uscire dalla povertà miliardi di persone.
È una distinzione fondamentale. Proprio facendo leva su questa distinzione, possiamo e dobbiamo proporre un nuovo ordine mondiale, alternativo a quello muscolare di Trump, e che passa per un accordo con la Cina e con i paesi del Sud del mondo: libertà di commercio in cambio di un accordo globale sulla finanza (che favorisce politiche progressiste in Occidente e non solo). Ne guadagnerebbero la stragrande maggioranza degli esseri umani, ci perderebbe, di sicuro, solo una minoranza di ultramiliardari rentiers. Aggiungo che la liberalizzazione del commercio deve essere comunque vincolata a principi etici: al rispetto dei diritti sociali e ambientali. Le merci e i servizi prodotti tutelando l’ambiente e i diritti dei lavoratori non devono avere dazi.
Questo dovrebbe essere l’approccio delle forze progressiste, una visione opposta a quella di Trump. Ed è il primo passo, concreto, per obiettivi di cooperazione ancora più ambiziosi: lotta alle disuguaglianze e alla povertà su scala internazionale e politiche ambientali condivise, rafforzamento dei beni pubblici globali, condivisione della ricerca di base in cambio di passi avanti sui diritti civili e politici, accordi per il disarmo, scioglimento contestuale dei G7 e dei Brics (per concentrarsi sul G20), riforma e rafforzamento delle Nazioni unite.
Questo dovrebbe essere oggi l’orizzonte ideale della politica progressista e democratica, illuminato dalla stella polare di una Costituzione della Terra, come quella proposta da Luigi Ferrajoli.
Tutto questo, partendo dalla coerenza di chi si proclama difensore dei diritti umani e dello stato di diritto. Una coerenza che noi occidentali dovremmo praticare innanzitutto al nostro interno, ma che oggi purtroppo non abbiamo, come evidenzia più di tutti il genocidio di Gaza.
Al Festival dell’Economia critica di Milano hai sollevato una domanda ad alcuni relatori che giudico cruciale per prefigurare un modello che coniuga difesa ecologica e sviluppo umano: è possibile separare il paradigma della crescita da quello dell’innovazione e dei suoi incentivi?
Quindi come ci si può assicurare il benessere facendo a meno del vincolo dell’espansione economica a tutti i costi. Tu che risposta ti daresti?
Io penso che l’ecologismo sia (o può essere) un umanesimo. Non a caso l’ecologismo ha anch’esso radici nella Rivoluzione scientifica, in quel processo che va da Copernico a Darwin e che, infatti, toglie l’uomo dal centro dell’universo e ristabilisce il legame fra noi e il mondo animale.
Ma soprattutto, l’ecologismo ha bisogno dell’innovazione tecnologica, non può certo fondarsi solo sulla riduzione (peraltro volontaria) dei consumi. Basti pensare che nel 1940 eravamo 2 miliardi di esseri umani, nel 1975 4 miliardi e oggi siamo 8,2 miliardi. Questa innovazione può e deve essere rivolta a ridurre le risorse necessarie al nostro benessere (pensiamo a quanto le auto e le fabbriche di oggi inquinino di meno rispetto al passato).
Il vincolo dell’espansione economica a tutti i costi è, invece, solo un’infrastruttura culturale creata dal capitalismo, utile ad alimentare il processo di accumulazione. Ma non è indispensabile. Se parlassimo di «innovazione» anziché di «crescita», e di «progresso» (cioè l’innovazione che tutela, ampia e rafforza i diritti) anziché di «sviluppo», allora cominceremmo a comprendere che l’economia e anche il nostro benessere non sono affatto, necessariamente, nemici della tutela dell’ambiente. Anzi possono diventare un prezioso alleato.
*Marco Bertorello lavora nel porto di Genova, collabora con il manifesto ed è autore di saggi su economia, moneta e debito fra cui Non c’è euro che tenga (Alegre, 2014) e, con Danilo Corradi, Capitalismo tossico (Alegre, 2011) e Lo strano caso del debito italiano (Alegre, 2023). Emanuele Felice insegna Storia economica all’Università Iulm di Milano. Il suo ultimo libro è Manifesto per un’altra economia e un’altra politica (Feltrinelli, 2025).